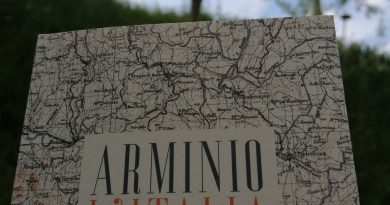E se Fitopolis nascesse in Appennino?
Nel nostro futuro c’è una città diffusa, senza centro, senza arterie, ma con mille connessioni invisibili, proprio come succede per gli alberi nei boschi. Una città fatta di piccoli paesi in rete tra di loro, ma anche di boschi, di terreni agricoli, di pascoli e di piccole e medie aziende. Una città nuova capace di replicare, in sostanza, quel che succede in natura; una città modulare, a misura del mondo vegetale, prima ancora che a misura d’uomo.
Il libro di Stefano Mancuso, Fitopolis, la città vivente, pur partendo da un’analisi spietata dei limiti e dei rischi delle città moderne, non arriva a queste conclusioni, ma suggerisce una soluzione diversa, altrettanto radicale: riempire letteralmente di alberi le strade delle nostre città. Mancuso, noto per i suoi studi sul mondo vegetale e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell’Università di Firenze, ha il grande merito di metterci di fronte alla necessità di ripensare le nostre città, utilizzando una visione ampia.
Però non tiene conto di un’alternativa molto italiana all’inevitabile crisi futura, o al collasso, delle città. Quest’opportunità riguarda un possibile e auspicabile nuovo modo di riabitare le aree interne, l’Appennino.
Ma andiamo con ordine.
Da troppo tempo ci siamo posti al di fuori della natura, dimenticandoci che rispondiamo agli stessi fondamentali fattori che controllano l’espansione delle altre specie. Abbiamo concepito il luogo dove viviamo come qualcosa di separato dal resto della natura, contro la natura. Ecco perché da come immagineremo le nostre città nei prossimi anni dipenderà una parte consistente delle nostre possibilità di sopravvivenza
Così scrive Stefano Mancuso che, a supporto, ci fornisce una serie di dati interessantissimi.
Oggi il 55% della popolazione umana vive nelle città che con la loro superficie coprono appena il 2,7% delle terre emerse del pianeta. Nel 2070 si prevede che la percentuale di abitanti delle città salirà al 70% di quella del pianeta.
Negli ultimi secoli abbiamo assistito ad una crescita esponenziale dell’urbanizzazione: si stima che la percentuale di popolazione urbanizzata nel 1600 fosse appena del 5%; nel 1800 dell’8% e nel 1900 del 616%.
L’Istat ci conferma che anche in Italia siamo a questi livelli: nelle cosiddette aree urbane funzionali (Fua) vive il 55,8 per cento della popolazione italiana. La Fua più grande è quella di Milano (con quasi 5 milioni di abitanti), seguita da Roma (4,3 milioni), Napoli (3,3 milioni) e Torino (1,7 milioni).
La concentrazione nelle città – sottolinea Mancuso – è una svolta epocale per la nostra specie, paragonabile solo a quella che all’alba dei (nostri) tempi, 12mila anni fa, ci trasformò da cacciatori-raccoglitori nomadi, in agricoltori.
Così se per millenni siamo rimasti una specie generalista, capace di adattarci a tutte le condizioni offerte dai territori in zone diversissime del pianeta, oggi invece l’homo sapiens sta evolvendo in una specie urbana, specializzandosi in alcuni comportamenti e risposte a stimoli ambientali limitati.
È certo che finora in termini di accesso alle risorse, efficienza, difesa e diffusione della specie questa trasformazione è stata vantaggiosa. Ma è altrettanto certo che ci espone a un rischio terribile: la specializzazione di una specie è efficace soltanto in un ambiente stabile. In condizioni ambientali mutevoli diventa pericolosa. Il nostro successo urbano richiede, infatti, un flusso continuo ed esponenzialmente crescente di risorse e di energia, che però non sono illimitate. Inoltre, fatto decisivo, il riscaldamento globale può cambiare in maniera definitiva l’ambiente delle nostre città e costituire proprio quella fatale mutazione delle condizioni da cui dipende la nostra sopravvivenza
Anche su questi aspetti il libro di Mancuso fornisce dati e spunti importanti: dalla valutazione dell’impronta ecologica delle città, alla verifica del metabolismo urbano. Ad esempio: l’impronta ecologica di Roma misura 20 milioni di ettari, 200mila chilometri quadrati: questa è l’enorme superficie di cui ha bisogno una città come Roma per sopravvivere, per i suoi consumi energetici, per crescere e per svilupparsi. Da considerare che il 27% dell’impronta ecologica è dovuta al fabbisogno di cibo. Anche il metabolismo delle città non funziona bene, le città mangiano e assorbono moltissimo e non digeriscono sufficientemente i propri rifiuti e non li riutilizzano. Un altro paragone: un uomo-agricoltore preindustriale aveva un metabolismo energetico calcolabile in 2000 W, mentre un uomo di oggi ha un metabolismo di 12000 W, anche perché l’energia consumata non riguarda più, come in passato, i bisogni essenziali, ma anche quelli sociali.
Mancuso lega le sue previsioni funeste rispetto all’eccesso di urbanizzazione ai dati sul riscaldamento globale. Le città, dice, sono e saranno i luoghi meno adatti per proteggersi dagli effetti dell’aumento delle temperature. Di qui la soluzione di forestarle, trasformandole in Fitopolis, riempendole di alberi e ricostituendo un nuovo rapporto con il mondo vegetale. Anche perché, ricorda Mancuso, il mondo vegetale comprende l’86,7 delle forme di vita presenti sulla terra, i funghi l’1,2%, gli animali appena lo 0,3%, i microrganismi la parte restante. E insomma se vogliamo sperare di salvarci dobbiamo provare a imparare a convivere con chi si è adattato meglio di noi su questo pianeta…
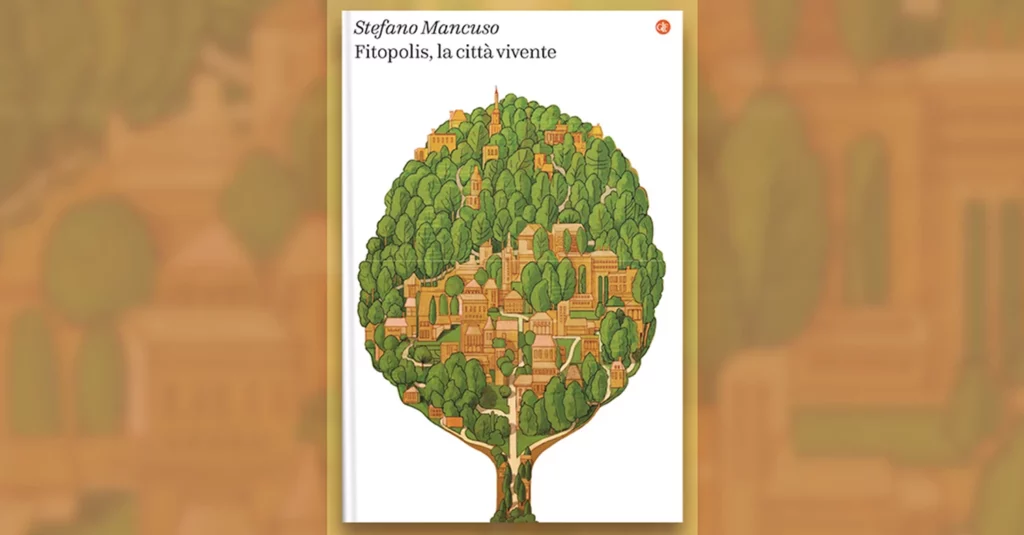
In “Fitopolis, la città vivente” si sottolinea la validità della strategia dei vegetali che ha contribuito alla loro diffusione. Alla base di questa strategia c’è innanzitutto la modularità: gli alberi e le specie vegetali non hanno organi singoli o doppi, come il cuore o i polmoni e possono quindi rigenerarsi molto più facilmente degli animali nel caso in cui abbiano subito danni. Certo le piante e gli alberi non si muovono, ma hanno un sistema di connessioni tra di loro e con l’ambiente circostante che ne tutela la sopravvivenza.
A questo punto però sarebbe stato interessante andare oltre e fornire anche altri dati: ad esempio quelli sulle aree interne, sull’entroterra italiano, che negli ultimi decenni ha subito un forte spopolamento proprio a vantaggio delle città. Nelle aree interne risiede oggi circa il 22,7 per cento della popolazione italiana, mentre questi stessi territori dove non ci sono grandi città ma piccoli o piccolissimi centri urbani, coprono oltre il 60% dell’intera superficie del territorio nazionale.
Questi centri, questi piccoli paesi, non hanno bisogno di essere riforestati, perché lo sono già. Anzi in alcuni casi se li stanno proprio mangiando i boschi. Offrono condizioni climatiche nettamente migliori rispetto a quelle delle città, sia per l’altitudine che per la permeabilità dei suoli e per la vegetazione. Sono oggi privi o carenti di servizi, ma un forte investimento sulla connettività e sul digitale potrebbe risolvere almeno in parte questi problemi.
Ma la lezione più importante che i paesi dovrebbero apprendere dal mondo vegetale tanto caro a Mancuso, è di non considerarsi mai più come entità separate: dovrebbero invece pensarsi e riprogettarsi in rete, potendo offrire servizi di territorio differenziati e complementari, come in parte sta già accadendo.
C’è qualcosa di più che una rete di paesi così concepita potrebbe offrire al posto delle città? Sì, certo. Riguarda il rapporto con il proprio territorio, quindi l’impronta ecologica della quale si accennava prima. I paesi non sono mai costruiti contro i propri territori, ma nei propri territori e anche i loro consumi tenderanno naturalmente ad adeguarsi alle produzioni locali. E questo potrebbe per così dire fare economia.
Da ultimo i paesi, quand’anche in rete, si suddividono in comunità a misura d’uomo, in dimensioni simili a quelle tanto care ad Adriano Olivetti, ad esempio, con una serie di vantaggi sociali ed economici. Inoltre chi si trovasse a vivere in questa nuova città diffusa a rete, si confronterebbe con un luogo e con il suo genio, piuttosto che con i non luoghi e le non cose delle megalopoli (delle quali ha parlato di recente anche il filosofo Byung-chul Han). E forse potrebbe tornare ad avere un rapporto diretto con la physis, ovvero con la natura e con i suoi cicli, determinati dal kosmos, che si vede guardando in alto, senza gli schermi delle città, dando luogo ad un approccio culturale completamente diverso, probabilmente più utile per la nostra specie, in prospettiva, oltre che per il pianeta. Così la Fitopolis d’Appennino può diventare anche Physiopolis.